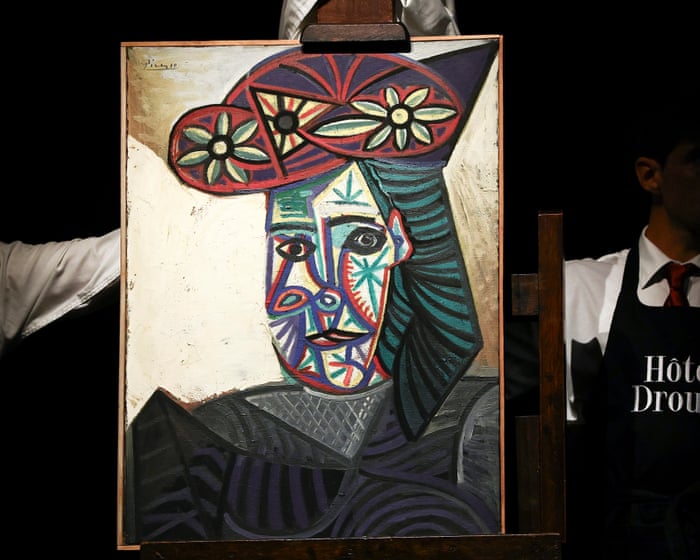Quasi 25 anni fa, quando pubblicai il mio primo romanzo, Haweswater, sugli effetti della costruzione di una diga nel nord-ovest dell'Inghilterra, la scrittura sulla natura mi sembrava diversa—almeno per me. Sebbene fossero già apparsi romanzi influenti sulla catastrofe climatica e sulla sopravvivenza, come Z per Zacharia di Robert C. O’Brien e La morte dell'erba di John Christopher, non c'era una pressione urgente ad affrontare questi temi. Quelle storie trattavano di disastri estremi e isolati—un virus mutato, una guerra nucleare—ed erano implacabilmente cupe. Colpivano nel segno, ma sembravano comunque eccezioni. Sul versante più leggero, Stark di Ben Elton usava la satira per denunciare l'avidità delle corporation, l'uso sconsiderato delle risorse e la rovina verso cui ci stavamo dirigendo—anche se oggi la sua premessa di miliardari in fuga nello spazio sembra meno divertente.
All'epoca, la gente era consapevole delle crisi ambientali, ma il linguaggio tendeva a concentrarsi su singoli problemi—il buco dell'ozono, il riscaldamento globale, la desertificazione, lo sbiancamento dei coralli—piuttosto che sul collasso totale dei sistemi terrestri. Esisteva una fantascienza visionaria, ma non si era ancora coagulata in un movimento. Gli scrittori avevano la libertà di ignorare le preoccupazioni climatiche, se lo desideravano—non c'era un tema incombente e inevitabile che richiedesse attenzione.
Negli anni 2000, mentre la scienza del clima si riprendeva dagli attacchi politici, emerse un'ondata di saggi allarmanti che avvertivano dell'aumento delle temperature globali, delle estinzioni di massa e del caos che sarebbe seguito se non avessimo cambiato rotta. Libri come Sei gradi (Mark Lynas), Un mondo senza api (Alison Benjamin e Brian McCallum) e Half Gone (Jeremy Leggett) suonavano l'allarme con una chiarezza spietata.
Come romanziera attratta da temi urgenti, ho risposto plasmando questi avvertimenti in narrativa. Il risultato fu The Carhullan Army, che immagina una resistenza femminile militarizzata in una Gran Bretagna allagata e autoritaria, dove vengono imposti razionamento e controllo demografico. Ripensandoci, vedo che è nato da una fascinazione terrorizzata per il collasso ecologico—e per i sistemi oppressivi, specialmente per le donne, che ne sarebbero seguiti. Volevo tradurre quegli avvertimenti in un'esperienza viscerale e immersiva per i lettori.
Altri scrittori facevano lo stesso. La strada di Cormac McCarthy, forse il romanzo più straziante del suo tempo, non nomina mai il suo disastro, ma mostra, come ha osservato George Monbiot, un mondo privato della sua biosfera. Un decennio dopo, The End We Start From di Megan Hunter dipinge un'Inghilterra allagata e in rovina, dove i sopravvissuti fuggono a nord. Gold Fame Citrus di Claire Vaye Watkins segue rifugiati controculturali in una California devastata dalla siccità, alle prese con un paesaggio così vasto e ostile da sfidare la comprensione. Quell'incomprensibilità—l'enormità della crisi ambientale—sarebbe presto diventata la nostra realtà condivisa.
Queste non erano minacce speculative, ma realtà in corso, che colpivano più duramente le comunità emarginate. Goliath di Tochi Onyebuchi esplora le dimensioni razziali e storiche del collasso climatico, seguendo afroamericani lasciati indietro in un Stati Uniti invivibile e soffocato dallo smog, mentre cercano significato e appartenenza. Chi soffre di più quando il disastro colpisce è una domanda centrale. Se queste storie offrono speranza o resilienza, è fugace, fragile o futile—come uccelli lontani che volteggiano in un cielo morente. Orfani cresciuti all'inferno, amore fragile, sorellanza. La speranza viene schiacciata o derisa dalla terrificante realtà di un pianeta morente. Da L'ultimo uomo di Mary Shelley, la paura di perdere la nostra casa e il nostro modo di vivere civilizzato ha alimentato storie distopiche. La climate fiction, o "cli-fi", è ora un genere fiorente, i suoi temi esposti negli scaffali delle librerie. Ma la disperazione è ancora il tono dominante?
Dicono che le utopie siano difficili da scrivere—e forse meno avvincenti da leggere. George Orwell sosteneva che "chiunque cerchi di immaginare la perfezione rivela semplicemente la propria vacuità". L'oscurità, d'altra parte, è intrinsecamente drammatica—provocatoria, avvincente e fin troppo familiare. Mentre gli sforzi politici per proteggere il nostro pianeta vacillano, le storie di orrore ambientale e di vendetta della natura potrebbero riflettere il nostro crescente fatalismo. La distopia serve da monito, per allontanarci dal disastro? O ci intrattiene semplicemente con visioni cupe, rafforzando gli esiti peggiori?
Ma Orwell ha ragione? Questo pessimismo potrebbe essere una profezia autoavverante, intrappolandoci nel caos invece di ispirare il cambiamento? Potrebbe soffocare narrazioni speranzose e approfondire il nostro senso di impotenza?
L'utopia di una persona è l'incubo di un'altra. Eppure la fantascienza ha sempre offerto visioni di progresso—come l'opera di Octavia Butler, che sfida gli istinti distruttivi dell'umanità e immagina nuovi percorsi evolutivi. L'afrofuturismo, nato da esperienze diverse da quelle di Orwell, esplora l'identità e l'agency nera, costruendo futuri di empowerment. Chi può dire cosa le storie possono o non possono fare?
Quindi, quale narrativa dovremmo scrivere ora? Questa è la domanda con cui ho lottato scrivendo Helm. La letteratura dovrebbe guidarci verso l'adattamento ambientale e la resilienza? Gli scrittori dovrebbero contrapporre alla catastrofe la speranza, rifiutando il pensiero apocalittico? Le storie possono davvero plasmare un futuro migliore—creando eco-utopie sulla pagina affinché possano esistere oltre di essa?
Durante un panel del British Council sulla scrittura della natura in Germania, un membro del pubblico ha posto proprio questa domanda. Robert Macfarlane, il moderatore, ha risposto senza esitazione: Sì. Io sono rimasta in silenzio.
Dopo anni di narrativa distopica, avevo provato la speranza in The Wolf Border, un romanzo sul rewilding e il recupero ecologico in Gran Bretagna. Un "E se?" speranzoso—o così credevo. Ma la sua premessa—l'indipendenza scozzese e una riforma radicale della terra—ora sembra più lontana che mai. Seduta a quel panel, mi sono sentita intrappolata da vecchie convinzioni: che l'oscurità sia il dominio della narrativa, che i romanzieri non siano responsabili di cambiare la mentalità della società. La mia libertà di scegliere un tema ambientale mi è improvvisamente sembrata vuota.
Per gli scrittori di saggistica, l'attivismo è centrale. Si impegnano direttamente con i problemi, usando le parole per protestare, fare campagna e ispirare azioni. Primavera silenziosa di Rachel Carson ha portato all'EPA. Black Faces, White Spaces di Carolyn Finney riesamina razza, natura e accesso agli spazi aperti, rimodellando le discussioni sulla giustizia ambientale.
La narrativa, tuttavia, fatica ad affrontare i problemi senza... In un mondo virtuale, ci sono innumerevoli elementi in gioco: personaggi, trame, paesaggi e temi. Una storia potrebbe evidenziare l'ambiente o addirittura centrarsi su di esso, ma questo non la rende un manifesto. È stimolante vedere scrittori come George Monbiot affrontare le cause profonde dell'inquinamento e dell'esaurimento—neoliberismo, capitalismo e le narrazioni radicate che ci fanno credere che le economie guidate dai consumi siano fisse e immutabili—proponendo al contempo alternative.
Anche la lettura di Wild Fell di Lee Schofield mi ha colpito profondamente. Il libro immagina un futuro fiorente di restauro ecologico negli stessi paesaggi in cui sono ambientati Haweswater e The Carhullan Army. È stato sorprendente perché non avevo mai immaginato una visione ottimistica per la mia regione—mi è sembrato un approccio narrativo che non avevo considerato prima.
Questo tipo di visione lucida e propositiva è notevole—un contributo ponderato al cambiamento sistemico. C'è anche un'ondata di libri potenti scritti da donne che esplorano il legame dell'umanità con la natura: falchi, lepri, montagne, terre comuni, fiumi. Queste opere iniziano a scalfire il senso schiacciante di fatalismo.
La narrativa può fare lo stesso. Il sussurro del mondo di Richard Powers mostra la forza dell'azione collettiva nel proteggere la natura. Flight Behavior di Barbara Kingsolver trova bellezza tra i cambiamenti planetari allarmanti che colpiscono tutte le specie. Questi romanzi esortano gli scienziati a parlare più forte e i lettori a impegnarsi più profondamente.
Questo è diventato la forza trainante di Helm, un libro sull'unico vento nominato della Gran Bretagna—un fenomeno antico ora minacciato dall'attività umana. Dopo anni di pause, riscritture e ripensamenti, ho iniziato a chiedermi se dovessi immaginare vie d'uscita da scenari carichi di catastrofe, piuttosto che limitarmi a ritrarre i conflitti al loro interno. La risposta è stata sì.
Sebbene il romanzo affronti il cambiamento climatico, il suo tono è diverso—forse per il suo soggetto: aria, leggerezza e una presenza sfuggente e mutevole. Che la natura narri se stessa non è nuovo in letteratura, ma ricordare che le storie umane sono inseparabili da quelle della natura è più urgente che mai. Il vento, voce centrale del libro, è un narratore malizioso, divertito dagli umani e indifferente alla propria distruzione—quindi il tono è giocoso, anche mentre sfiora l'apocalisse. Una sorta di distacco bellissimo potrebbe essere un modo per affrontare la rovina ambientale quando l'azione sembra impossibile.
Ma Selima, una meteorologa che studia le microplastiche nelle nuvole, porta un fardello più pesante. Affronta dure verità e interferenze dei negazionisti climatici. La sua lotta esistenziale riflette ciò che molti di noi proviamo come individui di fronte a crisi schiaccianti—eppure lei persiste, sfidante e collaborativa. La sua storia rimane aperta, lasciando spazio all'attivismo per prevalere.
Il romanzo intreccia storie dei tentativi dell'umanità di controllare la natura attraverso l'industria e la religione, trattandola come nostro "destino manifesto" da sfruttare. Ma esplora anche modi di vivere in armonia, riconoscendo il nostro posto nella natura—e il posto della natura in noi. Queste storie, spesso appartenenti a personaggi femminili, resistono alle forze distruttive e trovano parentela con il vento.
Attraverso la prospettiva di Helm, il romanzo offre una visione capricciosa ma profonda dell'umanità—che bilancia gravità e leggerezza, disperazione e possibilità. Questo progetto rappresenta l'impatto profondo dell'umanità sul nostro pianeta—il nostro egocentrismo e la nostra piccolezza nel grande schema—mentre si chiede: dove andiamo da qui? Ha innescato un cambiamento fondamentale verso la speranza e una nuova prospettiva. Alla fine, immaginare alternative positive alla nostra crisi ecologica è sembrato altrettanto significativo e necessario delle visioni distopiche che l'hanno preceduta.
Helm non è un'eco-utopia, ma spero che offra qualcosa di costruttivo per i nostri tempi. Ho sempre creduto che la narrativa possa aiutare i lettori a cogliere e abitare diverse versioni del mondo. Ora, sto iniziando a pensare che possa anche favorire visioni più sane del nostro ambiente—mostrando i nostri istinti migliori e immaginando che meraviglie come il vento Helm possano ancora essere salvate.
DOMANDE FREQUENTI
### **FAQ su "Idee luminose per il futuro: perché la climate fiction speranzosa conta"**
#### **Domande per principianti**
**1. Cos'è la climate fiction?**
La climate fiction, o "cli-fi", è un genere narrativo che si concentra sul cambiamento climatico e i suoi impatti, spesso ambientato in un futuro prossimo o lontano.
**2. Cosa rende la climate fiction "speranzosa"?**
La climate fiction speranzosa immagina soluzioni, resilienza ed esiti positivi nonostante le sfide climatiche, ispirando all'azione anziché alla disperazione.
**3. Perché la climate fiction speranzosa è importante?**
Aiuta le persone a immaginare un futuro migliore, motiva l'azione per il clima e combatte l'eco-ansia mostrando che il cambiamento è possibile.
**4. Puoi fare esempi di climate fiction speranzosa?**
Sì! Libri come *Il ministero del futuro* di Kim Stanley Robinson e *La parabola del seminatore* di Octavia Butler uniscono realismo e speranza.
**5. In cosa la climate fiction è diversa dalle storie distopiche?**
La narrativa distopica spesso si concentra sul collasso, mentre la climate fiction speranzosa enfatizza soluzioni, adattamento e ingegno umano.
---
#### **Domande avanzate**
**6. Come influisce la climate fiction speranzosa sull'azione climatica reale?**
Presentando futuri credibili, modella la percezione pubblica, stimola l'innovazione e incoraggia discussioni politiche.
**7. La climate fiction speranzosa ignora la gravità del cambiamento climatico?**
No—riconosce la crisi, ma sposta l'attenzione dalla catastrofe alla possibilità, rendendo il problema più risolvibile.
**8. La climate fiction può essere scientificamente accurata?**
Sì! Molti autori collaborano con scienziati per garantire scenari realistici, mescolando creatività e fatti.
**9. Come possono gli scrittori creare storie climatiche avvincenti ma speranzose?**
Bilanciando rischi reali con resilienza umana, soluzioni guidate dalla comunità e progresso tecnologico o sociale.
**10. Dove posso trovare più climate fiction speranzosa?**
Cerca liste di libri, podcast e comunità online dedicate al solarpunk, all'eco-fiction e alla fantascienza ottimista.
---
#### **Consigli pratici**
**11. Come posso usare la climate fiction nell'educazione o nell'attivismo?**
Assegna storie speranzose in classe o nei club del libro per stimolare discussioni su sostenibilità ed empowerment.
**12. Ci sono film o serie TV in questo genere?**
Sì!