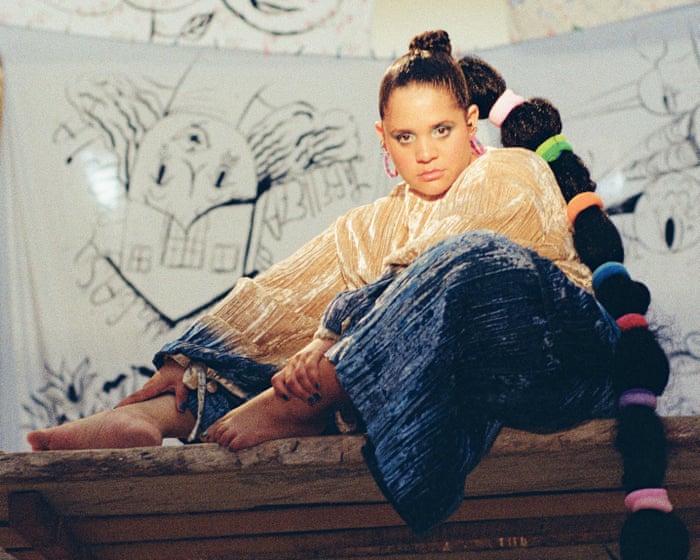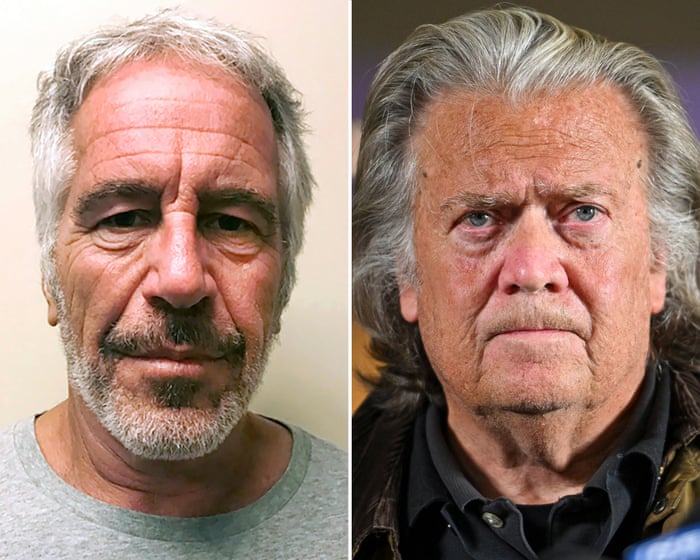Il detto "un'immagine vale più di mille parole" potrebbe non essere più valido. Con le immagini che inondano internet a un ritmo senza precedenti, il loro significato rischia di essere diluito—soprattutto con l’intelligenza artificiale che minaccia sempre più l’autenticità di ciò che vediamo. Ci si potrebbe chiedere perché il flusso infinito di immagini che mostrano l’inesorabile uccisione e devastazione a Gaza non abbia fermato il massacro dei palestinesi.
Ecco Juergen Teller, la stella ribelle della fotografia di moda degli anni '90, che ha ora pubblicato un libro da tavolino su Auschwitz, il campo di concentramento e sterminio nazista. È un mondo lontano dal suo solito lavoro. Teller divenne famoso per rendere brutte le cose belle—uno stile associato all'"autenticità", al grunge e alla cosiddetta "eroina chic" che lo rese il fotografo di moda più richiesto della sua epoca.
Intitolato semplicemente Auschwitz Birkenau, il libro è pubblicato da Steidl, il principale editore tedesco di libri d’arte, con una copertina disegnata da Peter Saville, la mente creativa dietro le opere iconiche dei Joy Division e della Factory Records.
Cosa c’è dentro? Fotograficamente, è deludente—documenta il sito così com’è oggi, preservato come memoriale contro l’oblio. Le immagini potrebbero provenire da un account Flickr anonimo. Come un turista troppo entusiasta, Teller cattura tutto a Oświęcim, la città dove si trova il campo: segnali elettronici per il parcheggio, fast-food kitsch e dettagli delle camere a gas. Non c’è gerarchia negli scatti, solo un senso di fretta. Tutte le oltre 800 foto sono state scattate con un iPhone con una semplicità ripetitiva—primi piani delle baracche, poi panoramiche; primi piani di lattine vuote di Zyklon B, poi inquadrature più ampie. Lo stesso approccio si applica a immagini cliché come "prospettive del filo spinato" e primi piani malinconici della neve che si scioglie.
Tra le foto si alternano testimonianze di sopravvissuti, raccolte da Christoph Heubner del Comitato Internazionale di Auschwitz, che ha invitato Teller a intraprendere questo progetto. Heubner ha anche guidato il padiglione Birkenau di Gerhard Richter, uno spazio espositivo inaugurato a Oświęcim lo scorso anno.
Il libro di Teller ha attirato la mia attenzione per il coinvolgimento di Heubner. Perché invitare un artista celebre—soprattutto tedesco—a documentare Auschwitz? Il problema non è che Teller sia famoso o che provenga dal mondo della moda. Il problema è che queste foto non aggiungono nulla alla nostra comprensione di Auschwitz. Sono del tutto insignificanti, non riuscendo a ottenere ciò che una nuova fotografia del sito dovrebbe: attirare l’attenzione su qualcosa precedentemente trascurato.
Si potrebbe sostenere che sia stato intenzionale—che Teller abbia deliberatamente represso il suo stile per rendersi invisibile. Ma non è invisibile. Nel Blocco 27, una baracca che ospita un’installazione interattiva sulle esperienze di sterminio delle nazioni, c’è un "Libro dei Nomi", ispirato a Yad Vashem, che elenca tutte le vittime conosciute di Auschwitz. Cosa fa Teller? Fotografa ogni pagina con il cognome "Teller". Certo, innumerevoli ebrei tedeschi furono uccisi nell’Olocausto. Ma isolare il proprio nome non è solidarietà—è narcisismo.
I tedeschi, come perpetratori, controllarono strettamente le prove fotografiche dello sterminio, assicurandosi che nessuna immagine trapelasse dai campi di morte. Ciò solleva una domanda cruciale e ancora attuale: la fotografia è davvero il modo giusto per confrontarsi con... L’Olocausto pone una sfida unica per la rappresentazione, poiché non esiste alcun registro fotografico originale. All’inizio di quest’anno, il Memoriale di Auschwitz ha creato una replica digitale del campo in risposta al crescente interesse dei registi (attualmente, solo i documentari possono essere girati lì). Le uniche immagini conosciute dei campi di sterminio sono le quattro foto del Sonderkommando—scattate di nascosto da prigionieri ebrei e fatte uscire clandestinamente—che hanno ispirato i dipinti di Gerhard Richter esposti nel padiglione di Oświęcim.
Sul muro del padiglione, una citazione di Richter recita: "Rappresentare le cose, catturare una visione, è ciò che ci rende umani." Ciò ha provocato critiche da parte dell’artista ebreo-tedesco Leon Kahane, la cui attuale mostra contrasta la prospettiva di Richter con quattro tele vuote, imitando il formato di Richter mentre ripete la citazione in tre lingue. Kahane abbina questo a foto di un recente raduno neonazista, riportando l’attenzione sulla realtà persistente dell’antisemitismo in Germania.
E se la vera umanità risiedesse nel non formare un’immagine? Le tele vuote di Kahane evidenziano un dilemma più profondo su come rappresentare l’Olocausto. L’approccio di Richter rischia di universalizzare il male, privandolo delle sue radici storiche e culturali specifiche. Tuttavia, almeno stimola un dibattito filosofico.
Lo stesso non si può dire per il libro Auschwitz Birkenau di Teller. La sua rappresentazione del campo è banale o sentimentale (includendo foto di kitsch da souvenir). In un momento in cui la memoria dell’Olocausto è sempre più politicizzata, il suo lavoro appare distaccato e vago, offuscando la responsabilità mentre sembra un progetto di vanità.
Visitare Auschwitz è diventato un modo facile per i tedeschi e altri per segnalare la loro distanza dal passato—per affermare di aver superato l’antisemitismo. Con libri come quello di Teller, alcuni potrebbero non sentire nemmeno il bisogno di quel gesto. Come artisti e come società, abbiamo un dovere verso la storia. Se Auschwitz diventa solo un simbolo vuoto e perdiamo la capacità di trasmettere il suo orrore, come faranno le generazioni future a capire che è davvero accaduto?
Agata Pyzik è una critica e autrice di Poor but Sexy: Culture Clashes in Europe East and West. Vive a Varsavia.
Hai riflessioni su questo articolo? Per inviare una lettera (massimo 300 parole) per una possibile pubblicazione, clicca qui.